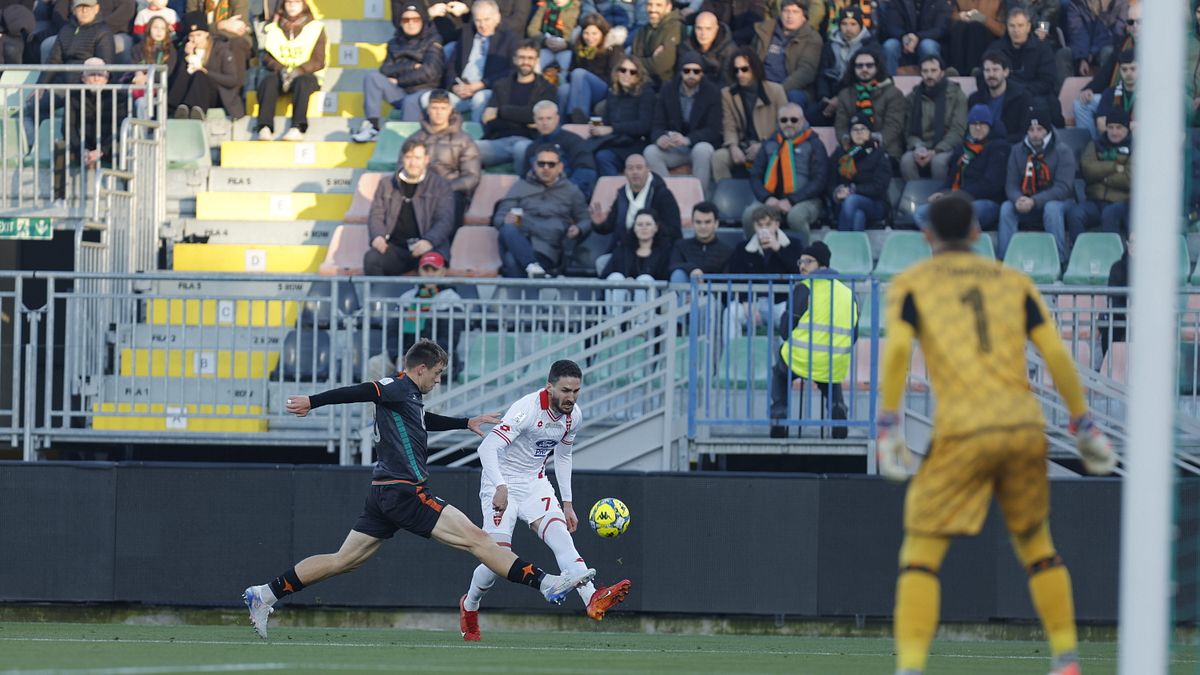Alfonso Gatto, un poeta allo stadio
Vita, calcio e ciclismo come un'unica testimonianza d'amore

Su Rione Forcelle, a Salerno, spira un vento carico di salsedine. Arriva dal mare – come fanno i mostri, i barbari, le pestilenze – e si attacca tenace ai muri delle case. Scartavetra gli intonaci, ormai arresi da tempo, e riempie i polmoni di chi, seduto all’uscio della porta, strappa all’estate una boccata d’ombra. Un’altra, e poi un’altra ancora. Si respira elemosinando quel tanto di frescura che basta, in questo reticolo di viuzze dispiegate come le venature sulla scorza di un melone. Le urla dei guaglioni, le vecchie che spuntano dalle tende, le lenzuola lasciate ad asciugare sui terrazzi. Qualcuno direbbe che è un buon posto per farci nascere un poeta. E infatti è proprio da uno di questi balconi che il giovane Alfonso Gatto scrive i suoi primi versi.
«Ero malinconicissimo – racconterà – e mi misi alla finestra».
È il 1928, il ragazzo non ha ancora vent’anni, ma per uno la cui poesia lieviterà al calore di questo sguardo essenziale, quell’affacciarsi-di-fuori ha la forza di un imprimatur. Lo si capisce prendendo in mano una qualsiasi foto che lo ritrae, non importa l’età: pare sempre che abbia il mare negli occhi, luminosi come scaglie di sole riflesse tra le onde. Intelligenti, malinconici, gli stessi immortalati dalla cinepresa di Pasolini ne Il Vangelo secondo Matteo, nel quale Gatto, amico di Pierpaolo, farà da comparsa. C’è più di una curiosa analogia tra i due, entrambi poeti ed entrambi esuli. Alfonso Gatto, infatti, che è destinato a diventare un maestro dell’ermetismo nostrano, lascia presto la Campania, indossando i panni del cantore itinerante e senza padroni: dapprima come antifascista convinto, in aperto conflitto col regime; poi da comunista dissidente e al di fuori del partito.